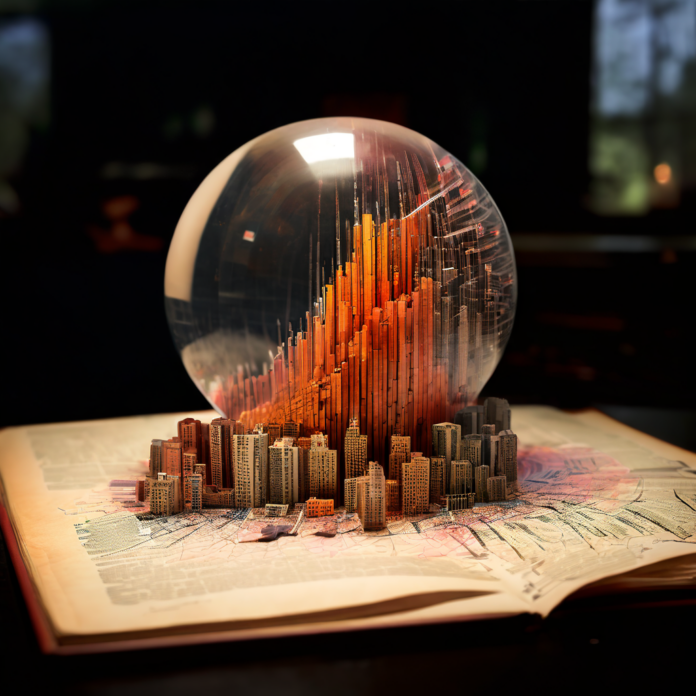Può il giornalismo evitare la propaganda?
A cura di Mattia Siragusa*
Una questione di primaria rilevanza
In un mondo in cui l’informazione viaggia velocissima e riesce a coprire costantemente ogni campo di interesse, dalla politica internazionale al gossip, con un livello di dettaglio sempre maggiore, è facile dimenticarsi il ruolo che in questo ha la narrazione. L’importanza della narrazione nell’informazione, infatti, torna all’attenzione del grande pubblico quasi esclusivamente in occasione di grandi conflitti, come si osserva di questi tempi.
Questo per vari motivi. In primis, è in questo tipo di eventi che la gente comune avverte in modo particolare la necessità di restare informata sui fatti, e si trova quindi davanti al problema di ricercare le informazioni che ritiene migliori. Ciò porta inevitabilmente ad imbattersi in voci diverse che raccontano il conflitto attraverso narrazioni che portano avanti determinati punti di vista. Inoltre, nei conflitti di grande portata, come quelli attualmente in corso in Ucraina e in Medio Oriente, l’informazione svolge un ruolo attivo nell’evoluzione stessa degli eventi, proprio perché il prevalere in un dato momento di una certa narrazione influenza anche le decisioni degli organi di potere coinvolti nel conflitto.
Cosa intendiamo con “narrazione”?
Una narrazione presenta una versione dei fatti parziale, e spesso nasce per favorire gruppi di potere che si servono dei mezzi di informazione per diffondere nell’opinione pubblica idee a sostegno dei propri interessi. Ogni mezzo di informazione, per quanto obiettivo possa essere, promuoverà sempre un certo punto di vista attraverso una narrazione, anche inconsapevolmente. Se si considera che, per il cittadino medio, l’unico modo per essere informato sugli eventi di un conflitto in corso sono proprio quei mezzi di informazione, risulta evidente che l’esposizione ad un’informazione parziale è pressoché inevitabile. È chiaro quindi che la responsabilità principale della diffusione di idee e narrazioni parziali è principalmente, se non quasi esclusivamente, degli addetti all’informazione, i giornalisti.
La narrazione dei conflitti odierni
Rendersi conto della narrazione che pervade un certo campo d’informazione è più facile col passare del tempo: ripercorrendo, ad esempio, i primi mesi del conflitto in Ucraina tramite la copertura data dalle principali testate giornalistiche italiane, comincia ad essere chiaro il delinearsi di due principali punti di vista. Il primo, quello dominante, supportato anche dagli organi istituzionali italiani ed occidentali, secondo cui il presidente russo Vladimir Putin avrebbe improvvisamente deciso di invadere un paese occidentale confinante per fini imperialistici, in un tentativo di riconquistare parte dell’area di influenza perduta in seguito al crollo dell’Unione Sovietica.[1]
Il secondo, opposto al primo, vede la Russia come un paese messo in difficoltà dall’espansione trentennale dell’alleanza NATO, e che, sentendosi in pericolo, ha reagito cercando di salvare la propria integrità occupando dei territori strategici già culturalmente affini a sé.[2]
Se è vero che una delle narrazioni potrebbe essere considerata più accurata o “meno errata” dell’altra, ad un’analisi dei fatti più lucida, possibile solo col passare del tempo, emerge che entrambe dipingono un quadro decisamente incompleto della vicenda e quindi, giungendo agli organi di potere, possono portare a decisioni poco lungimiranti.
Senza entrare troppo nei dettagli, è facile vedere come le narrazioni di cui sopra si conformino comodamente agli interessi di una parte e dell’altra del conflitto. Se una narrazione è utile ai principali gruppi di potere di una nazione, inoltre, è probabile che essa diventi rapidamente mainstream, e condizioni massicciamente l’opinione pubblica per creare una base di consenso che sostenga le decisioni politiche e strategiche riguardo il conflitto. Le masse vengono quindi di fatto manipolate, e i cittadini affrontano le conseguenze di scelte non pienamente consapevoli che spesso possono andare a scapito dei loro interessi. Nel caso della guerra in Ucraina, la massiccia campagna di informazione iniziata a seguito dell’attacco del febbraio 2022 ha diffuso una narrazione molto polarizzata a sostegno della resistenza ucraina, che ha escluso in modo netto ogni possibile messa in discussione delle decisioni del governo riguardo il conflitto: quando nei talk show qualche analista provava a raccontare in modo più approfondito le cause e le circostanze storiche della guerra in corso, infatti, veniva rapidamente messo da parte e gli erano affibbiati epiteti dispregiativi come “filorusso”, “filoputiniano”, “pro-Putin” e simili. Questo approccio non rende automaticamente sbagliata la linea politica intrapresa dal governo, ma rende evidente un allarmante uso propagandistico dei mezzi di informazione da parte della politica e, in generale, dei gruppi di interesse nel nostro paese.[3]
Lo stesso fenomeno si è potuto osservare negli ultimi mesi, quando, a seguito della risposta israeliana agli attacchi subiti il 7 ottobre 2023, i media italiani hanno tentato di riproporre lo stesso tipo di narrazione del caso precedente. Anche in questa occasione, chiunque tentasse di analizzare in modo più ampio la grande complessità del contesto è stato inizialmente messo da parte e additato come “pro-Hamas”, in opposizione ai “pro-Israele”, fautori invece della narrazione “corretta” a sostegno della linea del governo.[4] Questo approccio però, a differenza del caso ucraino, non ha avuto lo stesso successo, a causa della maggiore consapevolezza da parte dell’opinione pubblica della situazione in corso che gli ha opposto resistenza. Il risultato è che il dibattito è rimasto aperto a punti di vista diversi, e arricchisce i cittadini con un’informazione più approfondita e qualitativamente migliore anche attraverso i media più mainstream. La visione critica più ampia dell’argomento già presente nell’opinione pubblica ha contrastato il tentativo di strumentalizzazione della stessa, mostrando peraltro in modo più evidente questo meccanismo di propaganda.
Il confronto tra questi due casi è la chiave per mettere a fuoco gli obiettivi da porsi per un’informazione di qualità che sia da beneficio a tutti i cittadini, indipendentemente dalle narrazioni che la permeano.
Come ci si difende dalla propaganda?
Ciò che ha permesso ai cittadini di avere una visione più critica e indipendente riguardo il recente riaccendersi del conflitto israelo-palestinese è stata appunto la consapevolezza della complessità in gioco, frutto di una conoscenza del tema già presente nell’opinione pubblica. Questo evidenzia due fattori importanti per capire come si potrebbe affrontare il problema. Il primo dato è che l’opinione pubblica non va sottovalutata e si dimostra anzi perfettamente in grado di avvertire e poi contrastare un tentativo di manipolazione dei mezzi di informazione. L’altro punto cruciale è che questa coscienza non viene stimolata se non quando si ha già una qualche familiarità con la questione in oggetto. Da questo si conclude che un primo passo fondamentale per rendere i cittadini capaci di resistere alle ingerenze di narrazioni propagandistiche è quello di formare un’opinione pubblica consapevole dei contesti che la circondano e della loro complessità. Il compito del giornalismo è proprio quello di fare informazione: tenere i cittadini al corrente, nel modo più completo ed onesto possibile, dei fatti che li circondano.
Per svolgere questo ruolo al meglio è necessario, perciò, riportare informazioni su tutti i contesti che è possibile coprire, restando coscienti dell’inevitabile parzialità della comunicazione giornalistica. Ad essa si può quindi sopperire collaborando con altri professionisti dell’informazione per offrire una copertura degli eventi da parte di più voci, dando ai cittadini l’opportunità di costruire una propria visione al netto dei vari punti di vista presentati. Il cittadino deve essere informato in modo completo: non bisogna nascondergli i limiti oggettivi del mezzo di cui fruisce, ma anzi renderlo partecipe del processo di sintesi dei vari punti di vista. Questo rende ogni individuo più responsabilizzato nella scelta dei canali di informazione e più critico nei confronti delle informazioni stesse, capace di farsi un’idea dei fatti in modo indipendente dalle narrazioni esterne. Una massa di cittadini così formata ed educata (aiutata anche da un’istruzione che prepari al ragionamento critico) sarà molto più risoluta nel pronunciarsi riguardo i conflitti in corso, e soprattutto riuscirà a prendere decisioni poco controllabili dalle influenze sui mezzi d’informazione.
Prospettive concrete del futuro dell’informazione
Guardando al panorama mediatico odierno, italiano e non, una simile prospettiva appare però assai lontana. Se è vero che, come già detto, la responsabilità dello stato del giornalismo attuale è degli stessi giornalisti, è vero anche che gli interessi che tendono a strumentalizzare i mezzi d’informazione sono molto difficili da contrastare dal basso. Il singolo giornalista può fare poco per cambiare un sistema così grande e complesso. Eppure, egli rimane la sola figura in grado di intervenire attivamente sul problema. Occorre che una nuova generazione di giornalisti, capaci e determinati, si ponga come principale obiettivo il rinnovamento del giornalismo italiano in chiave anti-propagandistica, e si organizzi per contribuire collettivamente agli sforzi sopra descritti. Nell’ambito individuale, ciascuno invece può fare la sua parte sensibilizzando l’ambiente attorno a sé circa la necessità di essere informati correttamente e sui rischi delle narrazioni lasciate libere di circolare. L’obiettivo a lungo termine è quello di educare la popolazione al pensiero critico, all’importanza della pluralità delle voci, e al riconoscimento delle strategie che vengono utilizzate per promuovere intenzionalmente narrazioni parziali. Un risultato sicuramente molto difficile da ottenere, ma che vale senz’altro la pena di inseguire.
** Articolo vincitore del workshop “Covering conflict analysis and techniques of war reporting” organizzato da Hikma, febbraio 2024.
Note
[1] Enrico Franceschini, Perché è scoppiata la guerra tra Russia e Ucraina, Repubblica, 23/02/2023 https://www.repubblica.it/esteri/2023/02/23/news/motivi_guerra_russia_ucraina-388853698/
[2] Jerome Gauteret, La suadente campagna filorussa della tv italiana, Le Monde, 2022 https://www.internazionale.it/notizie/jerome-gautheret/2022/06/09/tv-italiana-russia [3]Alessandra Benignetti, “Ecco la lista dei putiniani italiani”. I nomi dei filorussi nel mirino del Copasir, Il Giornale, 2022 https://www.ilgiornale.it/news/cronache/ecco-lista-dei-putiniani-italiani-i-nomi-dei-filorussi-nel-2040019.html
[4] Francesca Galici, Cartelli pro-Hamas, la vergogna al corteo di Milano. E Salvini “Ultimi Fascisti”, Corriere, 2023 https://www.ilgiornale.it/news/nazionale/hamas-resistenza-non-sono-terroristi-cori-choc-corteo-milano-2236413.html
Foto copertina: la narrazione dell’informazione